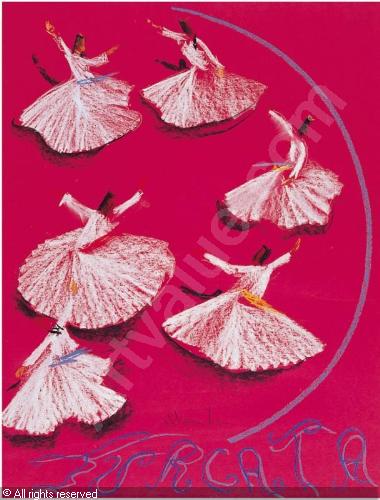“La verità non sta in un sogno ma in molti sogni”, afferma l’attore-regista Delbono nel prologo all’inizio de “ La Rabbia”citando "Il Fiore de le mille e una notte" di Pasolini, e , ancora aggiunge: ” alcuni provengono dalla nostra vita, altri dalle vite altrui e si mischiano, si confondono, si perdono nel nostro spettacolo”.
Così inizia la pièce di Belbono, in
questo monologare d’una voce al microfono che prosegue e si dilata, si tende come una
ragnatela immaginaria attraverso un montaggio di frammenti e brani musicali, in
un intercalare di parole o solo corpi, di grida e sussurri, di silenzi appesi a
un filo ed eclatanti esplosioni di emozione: desiderio d’amore o di bellezza, rabbia e rivolta nel continuo di un’ora ininterrotta di spettacolo. La scena è aperta, non ci sono sipario o quinte evidenti ma solo uno spazio vuoto, delimitato da una
parete-tenda nera sul fondo mentre entrano gli ultimi spettatori e i musicisti
sono già lì, a lato del palco, intenti ad accordare gli strumenti, a scambiarsi qualche parola e a provare poche note accennate da una chitarra o da un basso come se fossero in corso di prove, Delbono
già su scena con loro.

L’attore-regista si avvicina al
microfono accompagnato dal continuo d’una ballata per chitarra, inizia
questo monologare serrato, sussurrato e sussultante a tratti, in un primo
omaggio a Pasolini sull’eco di Rimbaud, abbandonandosi al fluire spontaneo
della parola, al suo scorrimento poetico; là la voce disegna e consuma, apre un
tracciato vibratorio, ritmico e musicale e poi lo svuota, lo interrompe, lo frammenta,
lo esaspera in una tensione emotiva che trascina nell’improvviso rapimento
vocale o nel repentino silenzio. Parole sussurrate o gridate intercalate dal
pause e note musicali al microfono riportano
l’amore a quella genuina primordiale passione d’eco pasoliniano che vibra nel sangue,
nel fremito della carne, in un desiderio sensuale che apre e eleva alla ricerca
di una inesausta, infinita bellezza, poi al movimento d’un pensiero che d’essa
si libera e si libra nel canto: “Nelle sere d’estate, trasognato lascerò che il
vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla ma l’amore
infinito mi salirà nell’anima,
stanco di infrangere i sogni rinascerà
libero da tutti i suoi dei”.
“Il
pensiero invisibile, eterno Dio che vive sotto la sua carne d’argilla salirà,
salirà, salirà
e
brucerà nella sua mente , tu lo vedrai scrutare l’orizzonte e ergersi
sprezzante di tutti i suoi ostacoli, libero da tutti i timori, splendido e radioso
gettato sul vasto universo. L’amore infinito in un infinito sorriso”.
“Il mondo ha sete d’amore” afferma il
prologo nel montaggio di frammenti poetici, esso salirà come un pensiero che si eleva
libero, senza timore dalla sua carne d’argilla; il troppo a lungo oppresso
pensiero si slancerà e salirà come un fremito d’amore vibrando sull’ ’immensa
lira dell’universo”. Se “la nostra pallida ragione ci nasconde l’infinito” afferma
il poeta, il senso di un sapere che oltre i limiti del qui e dell’ora apra a una
cristallina, luminosa visione- l'inesausta bellezza del vivente- “canta”, ripete il
poeta , canta un canto di sangue e d’amore. “L’amore è carne.. Danzate, ridete..Canta
la pietra, l’odore della terra perché anche il bosco canta e il fiume mormora
un canto pieno di felicità che sale, sale, sale verso la luce. E’ la ritenzione..l’amore”. Il trattenere qualcosa su di sé per
poi donarlo espanso, amplificato, rinato in un canto nuovo , nel gesto gratuito
d’una parola che diviene salute, redenzione o
salvezza.
Silenzio totale in sala alla fine del
monologo, assoluto e carico d’attesa. Delbono è dietro il microfono per la
maggior parte del tempo, i musicisti a lato mentre sulla scena aperta si susseguono un montaggio di storie di
corpi e estratti di testi, oppure brani musicali che alternano ironia e leggerezza a quei
momenti di rabbia feroce o di disperazione prima, di grazia o di candida presenza
quasi rubati al tempo e sospesi in un istante di poesia.
Camaleontico, versatile, penetrando
nella dimensione del ricordo personale e collettivo Delbono in un alternarsi di
ruoli e tonalità veste ora i panni e le movenze di un contadino genovese dal
cappello di feltro sformato nella memoria del padre, i suoi gesti e parole, la barba
sfatta, le grandi braccia e la mimica grossolana mentre legge versi nel dialetto
della sua terra. Diviene poi Charlot mimando in controluce all’ombra d’un proiettore
circolare seduto su un sedia la postura infantile del personaggio come in un
ritorno all’infanzia del mondo mentre le sue parole affermano in un’atmosfera
vicina al sogno e all’incanto: “Ovunque
tu sia guarda in alto, il sogno torna a risplendere. Piano, piano usciremo
dall’oscurità verso la luce; pensa alla forza che fa crescere gli alberi, che
fa girare l’universo, che fa tremare la terra… quella stessa forza è dentro di
te”.
La sua mimica eccezionale, le sue
movenze tenere e goffe, il suo dialogare con un interlocutore immaginario
sulle note d’una tenue musica jazz lo trasformano a poco a poco nella figura metamorfizzata
di un invisibile altro: il grido folle e
rabbioso di un piccolo dittatore facendo eco al doppio hitleriano nell’omonimo film
dove Chaplin parodia il nazismo e il suo imperversare in Europa negli anni ‘40.
“Del favoloso mondo antico era rimasta soltanto la bellezza..e tu te la sei portata dietro..con un sorriso.. così ti sei portata dietro la sua bellezza, sparivi come un pulviscolo al mondo”. “Bellezza antica, tanto amata e ormai perduta”, afferma il monologo citando Pasolini, visione di un sogno o di un recondito passato, di un tempo prima del tempo, d’una nostalgia antica e senza rimpianto, di una quasi mitica memoria ritornando più come un sogno che come un referente reale preciso. Il monologo la evoca in un sussurro poetico, omaggio a Pasolini, mentre un uomo seduto a terra canticchia tra sé e sé, si trascina ubriaco bevendo da una bottiglia semi-vuota, inciampa, crolla, si ripiega, ricorda qualche stralcio confuso d’ una canzone popolare, si interrompe a tratti in sospensione malinconica o forse perché non ricorda più il resto del testo. Una donna piccola e insignificante- attore o attrice che sia non importa- entra avvolta da un velo bianco a strascico nuziale su abiti ordinari e avanza lentamente mentre le parole fuori campo continuano a evocare la perduta bellezza; a poco a poco, depone il velo al suolo, la sua massa leggera e fine simile a un nugolo di bianco tulle vaporoso. Si odono gemiti come d’un pianto in lontananza, un pianoforte accompagna, finché lo abbandona lì a lato della scena per mostrarsi metaforicamente nuda, esposta, svuotata, senza più barriere di fronte al pubblico.
“Dimmi
che mi ami”, afferma la voce fuori campo dell’’attore, “dimmi che mi ami”
ripete più piano, “che mi ami” sussurra, implora “che mi ami” grida, impreca, “
dimmi che mi ami” strepita, urla, esplode in un grido di rabbia e folle
esplosione acustica di suono mentre le parole si fanno violente, gridate
evocando una febbre, il cancro di un popolo, un delitto collettivo, occhi
chiusi, il materializzarsi di una rabbia cieca, feroce. Due corpi, un uomo e
una donna s’abbracciano prima gentilmente poi crollano al suolo, in un
abbraccio, una danza, una lotta, in una stretta colma di violenza e ritenzione;
lottano, si gettano l’uno sull’altro mimando un’immobile, ritornante amplesso,
si separano e si riavvicinano, si fronteggiano e infine restano immobili, nel
silenzio privi di vita facendo eco, indirettamente, agli antecedenti del
teatro-danzato bauschiano.
“Sui
miei stracci sporchi, sulla mia nudità , scrivo il tuo nome, sui miei fratelli,
sul mio primo fratello, sul mio secondo fratello sciancato, sul mio terzo
fratello lustrascarpe, sul mio quarto fratello mendicante, scrivo il tuo nome, libertà, sui miei compagni di malavita, sui
nomadi del deserto, sui braccianti di Beirut,sui salariati di Oran, sui piccoli
impiegati di Algeri, scrivo il tuo nome, libertà,sulle misere genti di Algeri,
sulle popolazioni analfabete dell’Arabia, su tutte le classi povere
dell’Africa, scrivo il tuo nome, su tutti i popoli schiavi scrivo il tuo nome:
libertà” .
Ancora un grido nello spettacolo,
ancora un’esplosione di rivolta e di rabbia; una denuncia aperta, senza
compromessi o mezze misure è lanciata prima come un’asserzione precisa, fredda e
tagliente poi come un grido di rivolta feroce e assoluto, esplodendo spietato
sulla scena. Questa volta è la voce di un intellettuale impegnato e politicamente
non allineato alle forze governanti nell’ Italia a lui contemporanea: coscienza
d’una voce libertaria che dice “io so i nomi dei colpevoli delle stragi di
Milano, Brescia e Bologna”, e grida ancora “io so, io so i nomi”, denunciando
pubblicamente la politica italiana dell’ultimo trentennio , la connivenza tra
politicanti e mafiosi, le manipolazioni del denaro pubblico, le stragi
terroristiche degli anni 70, infine il volto cieco di un Potere responsabile, secondo
Pasolini, dell’omologazione totalizzante e generalizzata di tutte le classi
sociali attraverso l’imporsi della nuova società dei consumi e dell’edonismo. “Io so i nomi” continua l’invettiva perché
sono uno scrittore e un intellettuale che vuole comprendere, conoscere, sapere
ciò che se ne scrive o se ne dice, immaginare ciò che non si sa o si tace, mettere
insieme fatti disorganizzati e frammentari in un intero quadro politico, “ristabilire
insomma la logica là dove sembra regnare l’arbitrarietà, la follia, il
mistero”. “La rabbia” è anche quella di un Pasolini critico della società italiana, testimone della
sua radicale trasformazione, acculturazione e appiattimento nel giro di pochi
decenni, lui fino alla fine non allineato alle logiche capitalistiche contro i
quali oppone la forza di un pensiero libero e di un’arte autonoma, non
sottomessa alle dittature mediatiche e politiche più diffuse.
La rabbia coesiste con una pioggia di
coriandoli nell’atmosfera d’un sogno ad
occhi aperti nel finale. Si balla sulla memoria e le note d’una canzone popolare, un tango dalla sensualità
argentina lenta ed avvolgente, implicito omaggio a quell’atmosfera bauschiana
di riso nel pianto, a quella sua ironia o ieratico distacco al più profondo
delle passioni umane, all’anarchia o al dolore che governa le emozioni e le
relazioni più intime tra gli individui, alla follia dell’ordinario come al montaggio dei
frammenti apparentemente aleatori d’una soggettivante esperienza.
Personaggi con ali di angelo ballano in
festa nel finale tra polvere di coriandoli e l’atmosfera surreale, nostalgica
di un sogno ad occhi aperti o d’ un ritorno a una tenera memoria d’infanzia. Ali
d’angelo compaiono su un uomo in bicicletta che scorazza attraverso la scena, su
una donna bon ton anni ‘60, su un nano in tailleur scuro mentre la pioggia
bianca continua a cadere sul cerchio degli attori, su Delbono stesso autore-attore,
sull’eleganza accattivante, infine, di un’attrice soubrette che, in omaggio
alla Bausch, mima un passo a due lento e avvolgente con uno sconosciuto su quel ritmo nostalgico e sensuale.