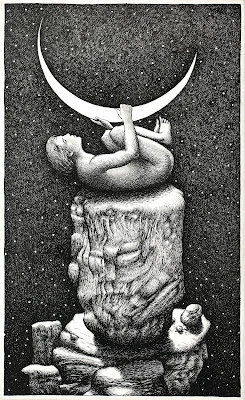E’ un De Chirico
inusuale, certamente meno noto e acclamato ma altrettanto ricco di suggestioni e
rimandi in controluce alla prima pittura metafisica quello che appare nella
mostra di Palazzo Pallavicini, “De Chirico e l’oltre” visitabile fino al 12
marzo a Bologna. La prima parte delle opere esposte infatti appartiene al
periodo della cosi detta produzione “barocca” ove l’artista lasciata Parigi per
ristabilirsi definitivamente in Italia, ( da Milano a Firenze approdando infine
a Roma) trae ispirazione dai grandi maestri del passato quali Rubens,
Tintoretto, Delacroix o Renoir. Opere barocche che superando l’apparente
naturalismo nella citazione quasi “post-moderna” dei grandi maestri della
tradizione pittorica occidentale si pongono definitivamente in un ottica dell’oltre, vale a dire ancora
una volta nel superamento della natura verso la creazione di una visione
onirica e irreale: “una finzione più vera del vero”. Nella seconda parte del
percorso espositivo ricompaiono opere della stagione neo-metafisica appartenenti
all’ultima parte della produzione artistica dechirichiana ( 1968-78) tra cui le
suggestive ambientazioni delle Piazze d’Italia, le enigmatiche composizioni di
oggetti e gli emblematici manichini rivisitati però con ironia, qui in forme
più serene e giocose. Il percorso espositivo ci immerge in questa esplorazione
di opere meno usuali e poco conosciute del grande maestro della metafisica che
tuttavia riconducono in qualche misura, seppur in maniera differente dal
periodo dell’avanguardia, a un
superamento della realtà oggettiva, certamente dello sguardo naturalista per
esplorare attraverso la finzione l’enigma annidato dentro le cose, una loro
paradossale verità in quel presunto gioco di non-vero.
Bagnanti
con drappo rosso nel paesaggio ( 1945)
E’ una visione di donna
voluttuosa vista nella sinuosità di forme dall’apparenza realiste del corpo
femminile ma che rinviano all’ideale barocco di una musa accogliente e
voluttuosa, ammaliatrice, avvolgente nelle forme là dove il pittore rivisita il
tema delle bagnanti in una variante moderna e seducente. Lo sguardo della donna
ipnotico e incantatorio oltrepassa la semplice rappresentazione realista invitando
già nel drappo rosso vivo che le modella il corpo alla carnalità, all’erotismo
o a un’idea di implicita seduzione nell’immaginario dello spettatore.
Composizione
con agnello (1947)
Ancora in un De Chirico
barocco e figurativo è questione di spingere lo sguardo oltre l’apparenza
oggettiva delle cose, per “veder la realtà oltre la realtà”, sviscerare la
natura soggettiva dell’evento attraverso una finzione che riesce a rivelarsi
“più vera del vero”. E’ l’immagine dell’agnello macellato che oltre la natura
morta raffigurata appare come l’animale votato al sacrificio, la vittima votiva
oggetto di olocausto arrestata nella sofferenza dell’oltraggio, nel mentre
dello sgozzamento là dove l’espressione del suoi volto umanizzato si staglia in
composizione frammentaria sull’immobile carne macellata tanto da rendere viva
la crudeltà, l’aspetto sacrificale del gesto ben oltre la figurazione.
Autoritratto
Gli autoritratti si susseguono nel corso della vita e della produzione artistica dechirichiana come forma di rispecchiamento e insieme implicita dichiarazione di poetica: atto attraverso il quale l’artista riflette su sé stesso e la propria concezione estetica. Da tale stagione figurativa emergono in particolar modo l’ “autoritratto in costume” e quello dove si mostra peculiarmente “nudo” di fronte al suo pubblico di interlocutori. Nel primo si rappresenta indossando un costume nobiliare del ‘600; si traveste in tale anacronistica visione del passato proclamandosi vicino ai grandi maestri del seicento là dove rinnega in qualche modo i valori modernisti di cui si era fatto portavoce nell’avanguardia. Appare tuffarsi in un ritorno alla tradizione pittorica barocca come via di fuga dal presente, nella citazione soggettiva di immagini provenienti da un passato rivisitato con la consapevolezza, certamente, dell’ insanabile frattura tra modernità e tradizione.
In “Autoritratto con corazza” la maschera
scelta dall’artista per raccontarsi in una sorta di autobiografia visiva è la pura
e semplice nudità. Si mostra nudo di fronte allo sguardo dei suoi detrattori,
critici e pubblico che l’avevano in qualche modo osteggiato rifiutando la sua
nuova pittura antimoderna. E in tale tela maschera intima, rimpicciolita di sé stesso
si mostra nudo nel suo corpo invecchiato, poco attraente, nella piena nudità
del suo essere artista in qualunque modo, amato e esaltato oppure vituperato e non
più compreso da critica e pubblico. Lo sguardo permane nei ritratti in primo
piano come antro rivelatore, là dove si
manifesta ciò che trapassa la maschera dell’apparire o i travestimenti che esso
assume per lasciar trapelare la natura incondizionata del creatore.
 “Due
cavalli in riva al mare” ( 1964)
“Due
cavalli in riva al mare” ( 1964)
La tela si rifà a uno
dei soggetti figurativi privilegiati da De Chirico nella serie dei cavalli dipinti
intorno al 1926 in riva al mare allo stato brado in mezzo ad antiche rovine.
Magnificamente delineati in linee morbide e spumose appaiono qui nuovamente mossi
dalla foga del vento circostante, selvaggi nell’andatura inquieta e tempestosa,
colti in un nitrire bizzarro e incontenibile di teste. Loro, avvolti in questo
vortice di schiuma e fluidi dalle acque del mare. Umanizzati, emergono dalla
tela come creature scalpitanti, vive,
quasi irreali oltre la barriera mimetica della figurazione. Si rivelano a noi
spumeggianti nella plasticità di forme mosse, incontenibili, non-finite.
Dechirico nell’ultima
parte della vita si lascia alle spalle l’ormai estinta ispirazione barocca per
ritornare a una reinterpretazione dei primi temi metafisici che lo avevano reso
protagonista indiscusso dell’avanguardia moderna. Ritornano le enigmatiche
visioni sulle Piazze d’Italia vuote, i manichini disumanizzati dall’evidente
portata simbolica, gli accumuli indecifrabili di oggetti antichi e moderni e
ancora le rovine o i templi classici che inondano le stanze borghesi. Muta
tuttavia, visibilmente, l’atmosfera e lo stato d’animo di queste ultime opere
neometafisiche dove non trapela più la precedente visione disincantata e
nichilista dell’universo_ la follia del mondo, il senso di spaesamento e
perdita di riferimenti, la malinconia devastante dell’individuo moderno a
inizio ventesimo secolo_ quanto un senso di accentuata ironia verso
l’esistente: una visione più serena della realtà dominata da colori accesi e
cadenze più giocose velate a tratti di una qualche malinconia.
Ne “Il pittore” (1958) ricompare
l’invenzione del manichino al centro dei suoi primi quadri metafisici come
alter-ego disumanizzato ma tanto più investito di sovra-senso simbolico ed evocativo.
Seduto su un cubo squadrato volge a noi
le spalle con lo sguardo puntato verso il varco aperto del paesaggio fuori; lui, concentrato nello studio della tela che
gli sta di fronte agli occhi a distanza. La stanza come la proiezione del suo
sguardo è questo reticolo di linee tracciate, di contorni stagliati e forme
geometriche in una nitida ricostruzione dello spazio. Posto di fronte a lui è, infine,
un altro manichino simile al suo riflesso su uno specchio deformato dove la
realtà è ricondotta al quod
essenziale del disegno.
Manichini ripensati in tale
inedita versione divengono “maschere”
nelle tele del 1970, visioni sovrapposte e contrastanti dell’io,sdoppiamenti o rivisitazioni
stranianti di sé stesso.
Maschere ancora
compaiono nell’intreccio dei due corpi in “La
tristezza della primavera”( 1970). Un albero rigoglioso nel pieno fiorire
della bella stagione annuncia l’affacciarsi della primavera sullo sfondo, ma i
due manichini non si guardano serrati in una stretta che potrebbe apparire un
abbraccio se non fosse impedita dall’intreccio delle linee sinuose sullo schienale
barocco posto lì ad trattenerli. Sono maschere nude che non si e guardano e corpi immobilizzati dal grigiore di linee
dense e sinuose pronte ad intrappolarli. Ancora in un’altra tela, “Ettore e
Andromaca” ritornano come manichini stretti l’uno all’altro; maschere ultra-umane
svuotate di identità si guardano senza vedersi, senza più occhi disegnati per a
riscattare il proprio destino di automi così
come la percezione di un mondo immerso nel caos e nell’incomprensione.
“Interno metafisico con officina e
vista sulla piazza” ( 1969)
Giocoso e ironico
diviene questo “interno metafisico” dipinto da De Chirico nel 1969 dove si
accentuano i colori accesi e i toni più sereni nella reinterpretazione dei temi
del passato. Dentro la stanza è un’agglomerato di oggetti e ritagli colorati di
forme all’apparenza indecifrabili che strutturano la realtà attraverso
un’architettura frammentata di sfaccettature cubiste. Un quadro dentro il
quadro si apre su questa dimensione del presente: “la fabbrica moderna”, un’officina industriale
con vista su una piazza deserta. Un altrove
metafisico, l’enigma della realtà che si nasconde dietro quella apparente
si affaccia dove oggetti iper-realisti come la fabbrica o la piazza assumono sembianze astratte e
irreali rimandandoci a quella malinconia e spaesamento delle prime ambientazioni
novecentesche. Ancora, è la consistenza della memoria, la citazione del passato
evocativa e nostalgica che si innesta, in un’unica composizione, sulla vivacità
del presente nella sua vena ironica, molto più lieve e disincantata.