Il teatro “straordinario” del quotidiano in quanto svelato, semplicemente da una macchina fotografica nel suo versante ora poetico ora ironico, sempre e comunque spontaneo, tale appare la fotografia di Vivian Maier in una “anthology” di più di cento immagini in bianco e nero e un piccolo numero di foto a colori accompagnate da un inedito Super8 mm attualmente presentate a Palazzo Pallavicini a Bologna fino al prossimo 28 gennaio. Se il gesto del fotografare come quello scatto casuale e istantaneo, quella ricerca del dettaglio che rivela o modifica la visione abituale ha accompagnato simile a una necessità o un’ossessione tutta la sua vita, il lavoro della Maier è rimasto nell’ombra fino al 2007 quando centinaia dei suoi negativi e rullini sono stati portati alla luce e divulgati da un collezionista americano per una contingenza di eventi, infine apprezzati a livello mondiale. La notorietà arriverà solo dopo la sua morte nel 2009 quando le sue fotografie saranno divulgate e esposte in una serie di retrospettive in tutto il mondo. Oggi più che mai il lavoro della fotografa americana spaziando dagli anni ’50 fino alla fine del XX secolo esplora il nostro rapporto complesso e continuo con il mondo di immagini di cui siamo circondati e sopraffatti nell’era digitale; allo stesso modo nella sua costante produzione fotografica, estemporanea e casuale, si rispecchia il quasi parossistico uso del visivo sul web e i social media attuali.
Tuttavia per la Maier, non dobbiamo
dimenticarlo, la fotografia porta in sé sempre e comunque, un riflesso della
propria interna visione, quindi in definitiva un modo per cercare sé stessa
in quel costante rispecchiarsi o
apparire come ombra, riflesso o silhouette tra le cose del mondo, in un mondo
dove non trova pubblico ruolo o riconoscimento come artista. Di qui la peculiare serie di ritratti e auto-ritratti visibili
nella mostra bolognese, rielaborati e ripetuti nel corso di una vita dove i
tratti personali si sovrappongono costantemente a quelli dei soggetti
fotografati.
New York, “Public library"
(1954)
D’avanti all’imponente facciata monumentale della biblioteca pubblica di New York il volto di una donna appare, elegante, incorniciato da una collana di perle e da un cappello che le tiene raccolti i capelli con stile, in uno scatto rapido e fugace probabilmente da un autobus in movimento. Lei, di profilo appare inaspettatamente vista camminare, persa tra i suoi pensieri come un volto sospeso, arrestato in quello spazio-tempo preciso, in quel momento di intimità svelato dallo sguardo attento e quasi in sordina della fotografa. La strada è per la Maier un teatro dove scorre la vita, il movimento, la miriade di volti del quotidiano, tutti potenziali soggetti al centro del suo obbiettivo. Un dettaglio o un gesto sul quel palcoscenico fanno la differenza ed è lì che compare, si esprime al meglio il potenziale della sua visione, per esempio in questo sguardo enigmatico, pensieroso quasi inquieto della donna colto sotto la maschera di eleganza e bon ton che ne cela l’apparenza. In quei dettagli si aprono spiragli unici di poesia, scorci eccezionali che ci fanno accedere alla sua più autentica visione.
Altri scatti nella stessa serie di “Street Photography”restano come punti di
sospensione aperti sulla realtà: l’enigma di un gesto da interpellare, scoprire
o cogliere semplicemente sul fluire della vita, del tempo o della memoria. Evidenziare
un dettaglio come mani che si stringono tra due fidanzati, le scarpe di un
uomo, i tacchi di una donna o lei vista di schiena perché secondo la Maier è nell’estemporaneo,
nell’arbitrario, nel minuscolo non visto che emergono le peculiarità, i gesti
inconsapevoli, quell’aspetto unico e irripetibile di ciascuno di noi che
costituisce un vero e proprio paesaggio dell’anima. Tale serie di foto sottratte dal teatro della strada delineano un
affresco complesso della realtà somma dei dettagli evocativi del quotidiano: gambe che
sporgono per caso sotto il ginocchio, gonne al vento, mani che nascondono, stingono,
accarezzano altre mani. Si tratta, in definitiva sempre, di un punto di vista
differente che sposta la focalizzazione piena e diretta della straight photography americana per
iscrivere l’idiosincrasia, la differenza o lo scarto significante del reale.
Childhood
L’infanzia è un tema che attraversa come una costante l’opera della Maier in quanto a stretto contatto con i bambini nel suo lavoro quotidiano di “nanny” tutta una vita. I bambini compaiono in maniera inconsapevole di fronte all’obbiettivo con la più grande empatia dell’artista oppure sono ritratti con naturalezza in strada nel quotidiano. Sempre e comunque visti con semplicità e poesia nel loro contesto, lontano dai miti d’America o dalle immagini stereotipate di un’ideale di infanzia edulcorata e fittizia. Spesso, al contrario, lo sguardo della Maier misura la distanza tra il loro mondo e quello degli adulti scegliendo punti di vista decentrati rispetto all’ottica frontale oppure ritagliata a misura del bambino, sul suo sguardo, sui suoi gesti e pose.
In una foto del 1962 per esempio
sono unicamente le gambe ad apparire, i tacchi a stiletto sul collant nero e la
gonna al ginocchio per la donna borghese e altolocata, il bianco dell’abitino e
calze a maglia della bambina, minuscola ,candida, irradiante rispetto alle
dimensioni immense della madre vicino. Si tratta ancora una volta del vedere,
inquadrare il mondo attraverso gli occhi del bambino tra la frustrazione verso
una realtà che sfugge ai suoi occhi e la contemplazione del gioco, posizionando l’obbiettivo lì, alla sua altezza
o nel punto di fessura, nella discrepanza tra i due punti di vista.
Auto-ritratti
Esistere nel mondo, essere e fotografare come una donna e un’artista; lasciare un segno, una traccia, vedersi mentre si guarda l’esterno, per esempio nel riflesso distorto di sé in uno specchietto dell’auto. E in quel gesto, in quella traccia incisa di luce propria ritrovarsi infine come donna e come fotografa. Tale la serie degli autoritratti o delle immagini scattate prima in bianco e nero poi a colori dove la Maier compare in sordina tra le cose o incorpora sé stessa in composizioni dove irrompe quasi per caso il suo riflesso o la sua ombra. In una immagine del 1955, la fotocamera Rolleiflex si staglia posizionata al centro della scena su un treppiede quasi fosse il fulcro di tutto il quadro mentre la fotografa appare poco più avanti offrendosi nel suo sguardo diretto e frontale a noi spettatori. Mentre lei fissa lo sguardo fuori e il suo riflesso attraverso lo specchio si staglia speculare al centro dell’obbiettivo resta forse la macchina fotografica la vera protagonista della composizione o, meglio, come Maier la definiva: “quell’extra paio di occhiali che ci aiutano a vedere il mondo un po’ meglio, un po’ più definito”. Sia che si tratti di sé stessa frontale in primo piano con aria investigativa, instancabile osservatrice della strade e di chi le abita, sia che si infiltri come un’ombra allungata al suolo, oppure come un profilo che d’un tratto rimbalza tra le cose per sfuggire via dall’inquadratura, sempre e comunque è con l’autoritratto che la Maier si confronta del tentativo instancabile di autodefinirsi, nella questione aperta sulla propria identità messa in gioco per trovare una strada nel mondo come donna e artista insieme.
Ritratti


Si tratta di anziani, vagabondi o
poveri colti perlopiù non visti per strada oppure in incontri reali, sempre e
comunque tenendosi a una certa distanza dal soggetto fotografato. Nei ritratti
sono spesso gli umili, i marginali o il decentramento del punto di vista
dominante di un’America bianca,
puritana, liberale e perbenista a comparire o, in ogni caso, a destare maggior
interesse. Così, le immagini che li ritraggono stabiliscono un rapporto di
distanza ma anche di dignità restituita nel sancire uno spazio fisico e mentale,
una barriera da non oltrepassare per lasciar parlare le loro intoccabile umanità,
singolare e irripetibile. Altrove, la fotografa si avvicina con sguardo ironico
e divertito ai ritratti delle classi più agiate, per esempio questo ricco uomo
d’affari americano ripreso nell’atto di fumare un sigaro guardando compiaciuto dall’alto
i grattacieli ai suoi piedi appena costruiti. L’obbiettivo della Maier si insinua lì con
ironia beffarda quasi tra le linee, mostrando con sarcasmo il volto di
un’America perbenista, benestante e autoreferenziale, totalmente centrata su sé
stessa e sui propri profitti. Tra i ritratti colti in strada, agli antipodi, un uomo intento a chiedere l’elemosine è fotografato
a propria insaputa dalla Maier. La fotografa sembra quasi voler illuminare la
sua invisibilità di indigente qualunque non visto in quella società luccicante
di fasto e benessere economico, come fosse uno di noi, rendendoci parte delle
sue stesse emozioni sulla base di una
comune umanità contro questa cecità di fondo del nostro tempo verso i marginali
e i reietti della terra.
Lo sguardo della Maier si posiziona
ancora frontale ma a distanza con una certa empatia ritraendo una serie di
bambini canadesi: il primo piano il volto imbrattato e gli occhi lucidi dopo un
pianto, l’espressione della bambina seria e accigliata e lo sguardo di sfida
frontale alla camera. Ancora due piccole si abbracciano in un momento di
naturale empatia estemporaneo e fugace che solo i bambini riescono a manifestare
nel gesto spontaneo di stringersi e guardarsi occhi negli occhi un istante. Infine,
un bimbo magro e timido, diffidente e quasi schivo all’obbiettivo guarda fisso
di fronte a sé la fotocamera come attraverso una barriera o un vetro invisibile
che lo separa da noi spettatori. Perché, come ha sempre inteso la Maier, tutto
il suo lavoro di fotografa nel corso di una vita nasce da questa “interna visione”, ora
spontanea e poetica, ora irriverente e ironica che illumina tuttavia il
soggetto attraverso lo scatto fotografico. Sempre, la sua fotografia porta
questo “ riflesso di sé” in ciò che crea, in quello che guarda. Sempre, l’artista
si insinua come una “spia nel mondo” tra le strade e attraverso i teatri più
comuni del quotidiano per “catturare voracemente quello che vede o che intende
vedere”. E in quel riflesso, di sé e del mondo attraverso l’immagine
fotografata, il lavoro della Maier non smette di porre la domanda sul senso e la
fotografia resta quella “lente extra di visione” che tenta di rispondervi; una miriade
di auto-ritatti per comporre l’intero quadro della sua visione.
Tutte le fotografie © Vivian Maier/Maloof Collection, Courtesy of Howard Greenberg Gallery, New York)












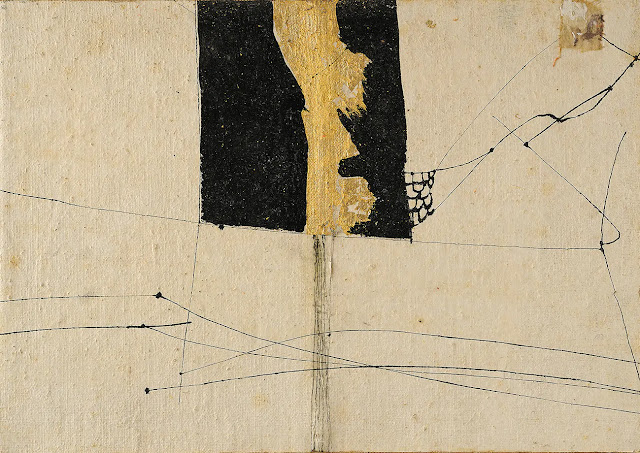














.jpg)









